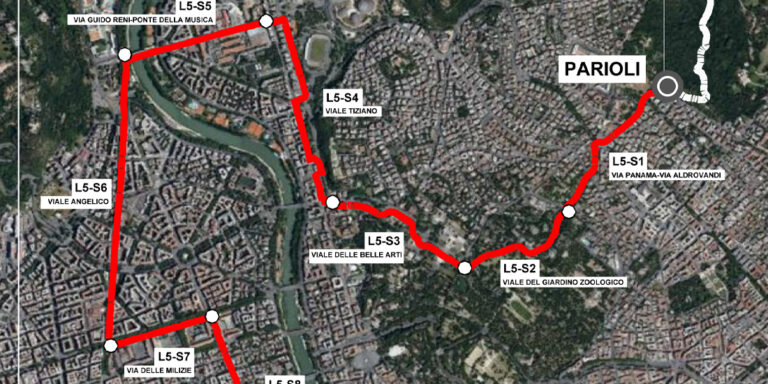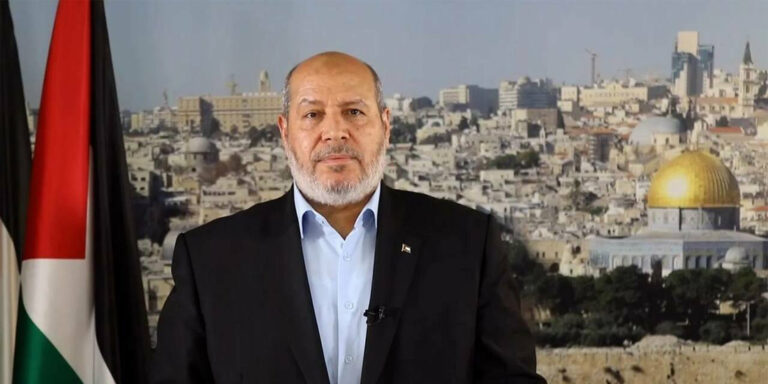Il primo ottobre 2025 segnerà una data storica per la sicurezza idrogeologica di Genova: entrerà in funzione la colossale TBM (Tunnel Boring Machine), la talpa meccanica arrivata dalla Cina che accelererà drasticamente i lavori di scavo della galleria dello scolmatore del torrente Bisagno. L’annuncio è arrivato al termine della riunione settimanale tra le aziende dell’ATI e l’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone.
Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e commissario di governo per le opere contro il dissesto idrogeologico, insieme a Giampedrone, ha sottolineato la portata storica di questo momento: “È un traguardo frutto della grande determinazione e volontà della struttura commissariale. Di fronte a tante polemiche da parte di chi non ci ha mai creduto, abbiamo lavorato sempre per superare le difficoltà, guardando avanti anche nei momenti più critici”.
La TBM rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica per il cantiere genovese. Con un peso complessivo di 1.280 tonnellate, la macchina arriva smontata dalla Cina, con il pezzo più pesante che raggiunge le 198 tonnellate. Il gigantesco macchinario, una volta a regime, riuscirà a scavare circa 20 metri al giorno, quintuplicando la velocità rispetto ai tradizionali metodi di scavo che permettevano di avanzare mediamente tre o quattro metri quotidiani.
Le operazioni di montaggio del colosso meccanico sono ormai in fase conclusiva. La talpa è arrivata nel porto di Genova nella prima metà di gennaio 2025, dopo un lungo viaggio dalla Cina attraverso la circumnavigazione dell’Africa. Il trasporto dalla Cina ha dovuto seguire questa rotta alternativa a causa del peggioramento della situazione geopolitica nei Paesi che si affacciano sul Mar Rosso, costringendo la nave della compagnia Cosco a doppiare il Capo di Buona Speranza.
L’impiego della TBM rappresenta una variante migliorativa introdotta nel progetto originale che ha permesso di ridurre i costi dell’opera di circa 800.000 euro e garantire il rispetto dei tempi contrattuali. La nuova macchina è completamente scudata, contenuta in un grande cilindro che comprende anche i meccanismi di posa automatica dei grandi conci di calcestruzzo durante la fase di avanzamento, garantendo maggiore sicurezza per i lavoratori e velocità di esecuzione.
Lo scolmatore del Bisagno rappresenta uno dei cantieri più importanti d’Italia e il principale della Liguria tra quelli attualmente in corso. L’opera, con un costo complessivo di oltre 200 milioni di euro, prevede la realizzazione di una galleria di circa 6,5 chilometri che collegherà la zona della Sciorba con il mare in corso Italia, permettendo di deviare le acque del torrente Bisagno e dei suoi affluenti Fereggiano, Rovare e Noce durante le piene.
La TBM cinese è stata acquistata per circa 20 milioni di euro, inclusi macchina e trasporto, mentre i costi lievitano a 25-30 milioni considerando i nastri necessari per raccogliere e destinare in discarica il materiale prodotto dallo scavo. L’appalto complessivo dello scolmatore ammonta a oltre 206 milioni di euro, gestito dal consorzio Research, capofila delle aziende costruttrici dell’opera.
Il progetto dello scolmatore ha origini lontane, risalendo agli anni 2000, e fu finanziato con il piano ‘Italia sicura’ nel 2015 dall’allora governo Renzi. I lavori sono iniziati concretamente nel maggio 2020, ma hanno subito rallentamenti significativi a causa di un’interdittiva antimafia poi rivelatasi infondata e successivamente rimossa.
L’importanza strategica dell’opera per la sicurezza di Genova è incommensurabile. Lo scolmatore avrà la funzione di diminuire la portata di piena idraulica del torrente Bisagno, deviandone una parte in galleria verso il mare. Questa infrastruttura avrebbe potuto evitare le tragiche alluvioni del passato: i 43 morti dell’alluvione del 1970 e le sei donne uccise dal Fereggiano nel 2011.
Il sistema dello scolmatore funzionerà in abbinamento con quello del Fereggiano, più piccolo e già attivo dal 2019, creando una rete di protezione idraulica sotterranea che garantirà sicurezza a migliaia di persone. L’opera sarà completamente invisibile una volta terminata, ma rappresenterà un’infrastruttura vitale per la città.
Giampedrone ha evidenziato l’accelerazione che l’avvio della TBM comporterà: “L’avvio della talpa segna una svolta nelle operazioni di scavo, che subiranno una forte accelerazione, con la necessità anche di ricalibrare costantemente i tempi di completamento dell’opera”. L’obiettivo è chiaro: portare a termine l’opera senza ulteriori rallentamenti.
Il cantiere in Valbisagno procede contemporaneamente su più fronti. Oltre al montaggio della TBM, proseguono i lavori con la realizzazione dei tre blocchi della sella per il posizionamento della talpa nella camera di lancio. Si sta inoltre riconfigurando l’arco rovescio in corrispondenza del camerone di montaggio, con getti che si sono protratti fino al dicembre 2024.
Una volta completato il progetto, la TBM potrà essere rivenduta ai cinesi al 20% del suo prezzo originale o riutilizzata per altri lavori, rappresentando anche un investimento tecnologico sostenibile per il futuro. Le previsioni indicano il completamento dell’opera entro giugno 2026, se non si verificheranno ulteriori imprevisti.
L’intero progetto prevede anche interventi complementari: oltre alla galleria principale, sono inclusi il ripascimento degli arenili e il ripristino ambientale e paesaggistico. L’opera rappresenta quindi un intervento complessivo di riqualificazione del territorio che va oltre la semplice messa in sicurezza idraulica.
L’entrata in funzione della talpa il primo ottobre rappresenta quindi molto più di un semplice avvio di cantiere: simboleggia la determinazione delle istituzioni liguri nel portare a termine un’opera strategica che cambierà per sempre il rapporto tra Genova e il rischio idrogeologico, trasformando una minaccia storica in una certezza di sicurezza per le generazioni future.