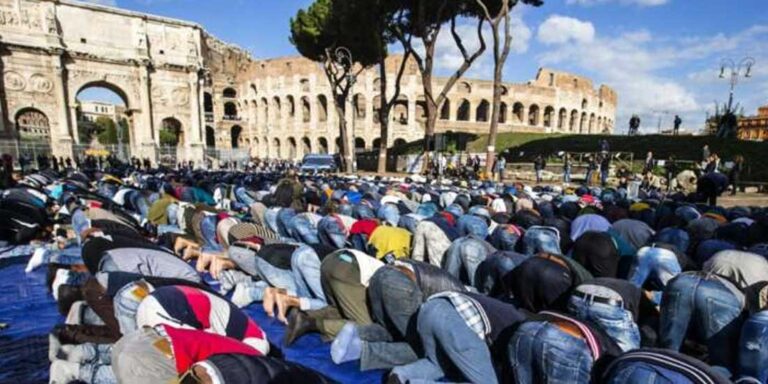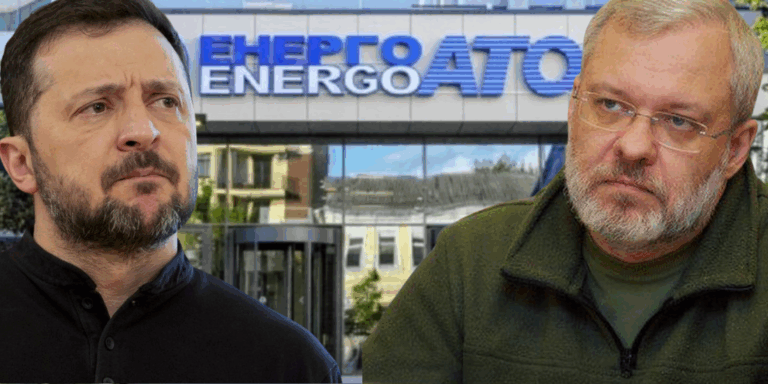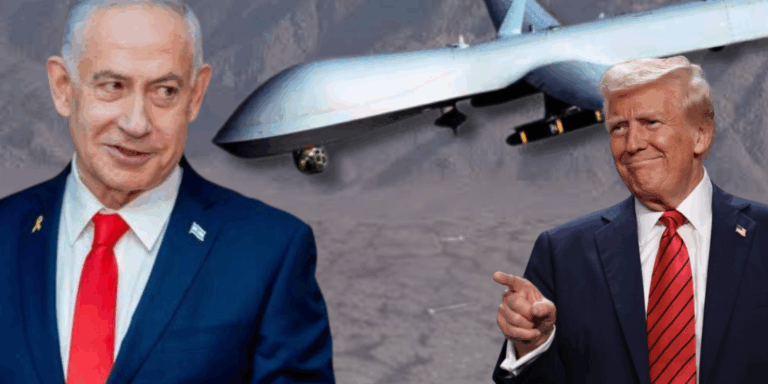Durante l’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi e tragici della storia moderna, si consumava un orrore che solo oggi viene alla luce con maggiore evidenza. Mentre la capitale bosniaca veniva bombardata quotidianamente ei suoi abitanti correvano tra le vie sotto il fuoco dei cecchini, alcuni facoltosi cittadini stranieri pagavano cifre esorbitanti per partecipare a quella che è stata definita una vera e propria “caccia all’uomo”. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta su questi presunti “safari umani” , un’indagine che potrebbe finalmente fare luce su uno degli episodi più macabri della guerra in Bosnia.
L’inchiesta è stata avviata dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, che coordina l’unità antiterrorismo della Procura milanese, sulla base di un esposto dal giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, assistito dagli avvocati Nicola Brigida e dall’ex magistrato Guido Salvini, figura di spicco della magistratura italiana nota per aver condotto importanti inchieste sul terrorismo e sulla strategia della tensione. Il fascicolo, aperto per volontario plurimo aggravato da motivi abietti e dalla crudeltà, è al momento contro ignoti, maomicidio l’obiettivo degli investigatori è chiaro: gli italiani che avrebbero preso parte a questi crimini efferati.
Secondo le testimonianze raccolte nel dossier di 17 pagine depositato a gennaio, i cosiddetti “cecchini del weekend” erano perlopiù uomini benestanti, appassionati di armi e spesso legati ad ambienti dell’estrema destra , che si radunavano nel nord Italia, principalmente a Trieste, per poi essere trasportati sulle colline che circondano Sarajevo. Da queste posizioni elevate, che dominavano la città, potevano sparare sui civili che tentavano disperatamente di attraversare le strade per procurarsi cibo e acqua. Le somme pagate per questa macabra esperienza oscillavano tra gli 80.000 ei 100.000 euro , cifre enormi anche per gli standard odierni, che garantivano ai “turisti della guerra” l’opportunità di sparare su esseri umani indifesi come se fossero prede in un safari africano.
Ma l’aspetto forse più agghiacciante di questa vicenda riguarda l’esistenza di un vero e proprio listino prezzi per le vittime . Secondo quanto emerso dalle indagini, sparare a un bambino costava di più, seguito dal costo per uccidere uomini armati in uniforme, poi donne, mentre gli anziani potevano essere presi di mira gratuitamente. Questa differenziazione tariffaria trasformava la vita umana in una merce, in un prodotto da acquistare per soddisfare gli impulsi sadici e il desiderio di provare l’adrenalina dell’uccisione senza conseguenze.
L’organizzazione di questi viaggi dell’orrore era complessa e coinvolgeva diverse figure. I partecipanti volavano da Trieste a Belgrado utilizzando l’infrastruttura della compagnia aerea serba Aviogenex, che negli anni Novanta operava anche collegamenti charter. Da Belgrado, gli aspiranti cecchini venivano poi trasportati via terra o tramite elicotteri dell’esercito jugoslavo fino a Pale , la cittadina a una decina di chilometri da Sarajevo che era diventata la capitale della Repubblica Serba di Bosnia, controllata dalle forze di Radovan Karadzic, il leader serbo-bosniaco poi condannato per genocidio e crimini contro l’umanità.
Una volta giunti a destinazione, i “turisti” sono venuti accompagnati da membri dell’esercito serbo-bosniaco alle postazioni di cecchini già operative intorno alla città. Qui ricevevano le armi e potevano sparare liberamente sulla popolazione civile. Alcune testimonianze hanno descritto scene in cui questi stranieri, facilmente riconoscibili per l’abbigliamento inappropriato al contesto di guerra urbana e per le armi più adatte alla caccia in foresta che al combattimento nei Balcani, venivano guidati quasi per mano da militari locali che conoscevano perfettamente il terreno.
Una delle testimonianze più significative raccolte da Gavazzeni proviene da un ex agente dell’intelligence bosniaca, identificato nel dossier con le iniziali ES, che ha fornito dettagli cruciali su come le autorità locali fossero venute a conoscenza del fenomeno. Questo testimone ha affermato che alla fine del 1993 i servizi segreti bosniaci informarono il SISMI, il servizio di intelligence militare italiano dell’epoca, della presenza di almeno cinque italiani sulle colline intorno a Sarajevo , accompagnati specificatamente per sparare ai civili. L’ex 007 bosniaco ha raccontato che le informazioni provenivano dall’interrogatorio di un volontario serbo catturato, il quale aveva rivelato di aver viaggiato da Belgrado alla Bosnia insieme a cinque stranieri, di cui almeno tre erano italiani e uno aveva dichiarato di provenire da Milano.
Secondo questa fonte, le comunicazioni tra l’intelligence bosniaca e quella italiana erano frequenti durante quel periodo, e le informazioni sui “safari” furono trasmesse agli ufficiali del SISMI presenti a Sarajevo all’inizio del 1994. La risposta italiana sarebbe arrivata due o tre mesi dopo, con l’assicurazione che i servizi avevano scoperto che i viaggi partivano da Trieste e che erano riusciti a bloccarli. Tuttavia, non furono mai forniti i nomi degli organizzatori o dei partecipanti, e la documentazione relativa a questa corrispondenza sarebbe conservata negli archivi bosniaci come materiale classificato “top secret”, accessibile solo tramite ordine giudiziario.
Questa rivelazione solleva interrogativi inquietanti sul livello di conoscenza che le autorità italiane avevano del fenomeno e sulle azioni intraprese per fermarlo. Se davvero il SISMI era stato informato nel 1994 e aveva identificato Trieste come punto di partenza avviati di questi viaggi, perché non furono effettuate indagini per identificare e i responsabili? La mancanza di azioni concrete da parte dello Stato italiano all’epoca potrebbe configurare responsabilità che ora i magistrati milanesi intendono accertare.
L’indagine di Gavazzeni non si basa solo su testimonianze orali, ma include anche riferimenti a documenti ufficiali ea procedimenti giudiziari internazionali. Nel 2007, durante il processo al comandante dell’esercito serbo-bosniaco Ratko Mladic presso il Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia all’Aja, un testimone chiave aveva già parlato dei “turisti cecchini” . Si trattava di John Jordan, un ex vigile del fuoco americano che aveva operato come volontario a Sarajevo durante l’assedio. Jordan aveva dichiarato di aver assistito in più occasioni alla presenza di persone che non sembravano locali, identificabili dal loro abbigliamento, dalle armi che portavano e dal modo in cui venivano guidati e trattati dai militari serbo-bosniaci.
Jordan aveva descritto questi individui come “tourist shooters”, turisti cecchini, e aveva spiegato che erano evidenti per il loro comportamento e per il fatto che portavano armi da caccia inadatte al contesto di combattimento urbano nei Balcani. Il vigile del fuoco aveva testimoniato di averli visti a Grbavica, uno dei quartieri di Sarajevo controllati dai serbo-bosniaci, e in altre posizioni di osservazione intorno alla città. La sua testimonianza aveva già sollevato dubbi e domande, ma solo ora, con l’inchiesta milanese, questi elementi stanno venendo collegati in un quadro investigativo coerente.
Un altro elemento cruciale dell’inchiesta riguarda il documentario “Sarajevo Safari”, realizzato nel 2022 dal regista sloveno Miran Zupanic e prodotto da Al Jazeera Balkans. Questo film di 75 minuti, presentato in anteprima al festival internazionale del documentario di Sarajevo nel settembre 2022, ha raccolto testimonianze e dimostra che hanno contribuito a riportare l’attenzione su questo fenomeno. Il documentario include l’intervista a un testimone protetto, un ex ufficiale dell’intelligence che ha raccontato di aver assistito personalmente a sette episodi di cecchini stranieri in azione tra il 1992 e il 1994 .
Questo testimone anonimo ha descritto con precisione le scene che aveva osservato: uomini venuti da lontano, chiaramente benestanti a giudicare dal loro aspetto e comportamento, che venivano accompagnati da militari serbo-bosniaci in posizioni di tiro strategiche. La tensione e l’eccitazione di questi “cacciatori” erano palpabili prima dell’azione, come se si preparassero per una battuta di caccia sportiva. Il testimone ha sottolineato le notevoli capacità di tiro di alcuni di questi individui, confermando che non si trattava di dilettanti ma di persone con esperienza nell’uso delle armi.
Il regista Zupanic ha cercato non solo di documentare i fatti, ma anche di indagare gli aspetti psicologici di persone disposte a rischiare la propria vita entrando in una zona di guerra ea pagare somme ingenti per il “piacere” di uccidere civili sconosciuti. Nelle interviste rilasciate per promuovere il film, Zupanic ha spiegato che è fondamentale comprendere quali meccanismi mentali possano portare esseri umani a comportamenti così aberranti. Esperti di psicologia intervistati nel documentario parlato hanno impulsi sadici che alcune persone riescono a controllare nella vita quotidiana ma che cercano opportunità per esprimere in contesti in cui possono farlo impunemente .
La proiezione del documentario ha avuto un impatto significativo. Benjamina Karic, all’epoca sindaca di Sarajevo, presentò nel settembre 2022 una denuncia penale contro ignoti presso la Procura bosniaca, allegando un rapporto sui “ricchi stranieri impegnati in attività disumane”. Tuttavia, le autorità bosniache hanno successivamente archiviato l’indagine, citando le difficoltà di procedere in un paese ancora profondamente diviso e segnato dalla guerra. La stessa Karic, che ha ricoperto la carica di sindaca dal 2021 al 2024, ha poi inoltrato nell’agosto 2024 una denuncia alla Procura di Milano tramite l’ambasciata italiana a Sarajevo , dichiarandosi disponibile a testimoniare e fornendo tutta la documentazione in suo possesso.
Karic ha spiegato che i giornalisti che lavoravano a Sarajevo durante la guerra, così come tutta la popolazione assediata, erano consapevoli della presenza di questi “turisti della morte”. Ha affermato che gli stranieri provenienti da tutta Europa pagavano ai checkpoint gestiti dalle milizie paramilitari serbe sia in Croazia che in Bosnia per poi trascorrere un fine settimana a sparare sui civili dalle colline che sovrastavano la città. La decisione di presentare denuncia in Italia nasce dalla constatazione che né la giustizia bosniaca né quella serba sembravano in grado o disposte ad affrontare seriamente la questione.
L’esposto di Gavazzeni contiene dettagli specifici che potrebbero rivelarsi fondamentali per l’identificazione delle responsabilità. Tra gli italiani segnalati nelle testimonianze raccolte ci sarebbe un imprenditore milanese proprietario di una clinica privata specializzata in chirurgia estetica, un uomo di Torino e uno di Trieste . Queste indicazioni, anche se ancora da verificare, forniscono agli investigatori piste concrete da seguire. Il pm Gobbis, insieme ai carabinieri del ROS, l’unità speciale dell’Arma che si occupa di antiterrorismo e criminalità organizzata, sta già pianificando di convocare i testimoni indicati nel dossier per raccogliere ulteriori elementi probatori.
L’inchiesta si inserisce in un contesto legale particolare. In Italia, il reato di omicidio aggravato da motivi abietti e crudeltà è punibile con l’ergastolo e non cade mai in prescrizione , il che significa che anche crimini commessi più di trent’anni fa possono essere perseguiti. Inoltre, secondo il codice penale italiano, se la fase finale di un crimine è stata commessa all’estero ma il responsabile è cittadino italiano, la giurisdizione italiana rimane valida e il processo può svolgersi in Italia. Questo impedisce che un cittadino possa commettere crimini orribili all’estero e poi trovare rifugio impunito nel proprio paese.
L’avvocato Nicola Brigida, che assiste Gavazzeni insieme a Salvini, ha un’esperienza significativa in casi internazionali complessi. Ha lavorato su procedimenti riguardanti cittadini italiani scomparsi in Cile e Argentina durante le dittature militari , partecipando ai processi contro l’ammiraglio Emilio Massera ei generali Suárez Mason e José Antonio Rivera della giunta militare argentina, figura chiave durante la dittatura tra il 1976 e il 1983. Si è occupato anche di casi relativi alle vittime dell’Operazione Condor, la campagna coordinata di repressione condotta dalle dittature sudamericane negli anni Settanta e Ottanta.
Brigida ha dichiarato che la documentazione presentata alla Procura di Milano è ricca di dimostrare che meritano di essere indagate ulteriormente e che è fermamente convinto che possano portare all’identificazione di almeno alcune delle responsabilità. Ha sottolineato che dopo aver lavorato su casi come i “voli della morte” in Argentina, questo caso presenta un profilo comune tra i perpetratori: persone malvagie, forse anche ideologicamente motivate, appassionate di armi, che frequentavano poligoni di tiro nella loro vita normale ma che cercavano esperienze estreme.
Guido Salvini, l’altro legale coinvolto, è un ex magistrato di grande prestigio che ha dedicato oltre quarant’anni della sua carriera ad indagini su alcuni dei casi più oscuri della storia italiana. Ha riaperto le indagini sulla strage di Piazza Fontana del 1969, ha investigato il terrorismo neofascista e la rete segreta Gladio , ed è stato consulente di diverse commissioni parlamentari d’inchiesta, tra cui quella sull’occultamento dei fascicoli relativi alle stragi nazifasciste e quella sul sequestro di Aldo Moro. La sua partecipazione al caso conferisce credibilità e peso all’iniziativa giudiziaria.
La Procura di Milano sta ora richiedendo gli atti di vari procedimenti del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia all’Aja, dove alcune testimonianze hanno fatto riferimento a questi “turisti della guerra”. L’obiettivo è incrociare le informazioni raccolte nel corso degli anni in diversi contesti processuali per costruire un quadro probatorio solido. Gli investigatori sperano anche di ottenere accesso agli archivi classificazione dell’intelligence bosniaca e, eventualmente, a documenti del SISMI che potrebbero confermare le informazioni trasmesse dai servizi segreti bosniaci nel 1994.
Non si trattava solo di italiani. Le testimonianze raccolte nel corso degli anni parlano di “turisti cecchini” provenienti da vari paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Russia, Regno Unito, Francia e Germania. Un caso ben documentato riguarda lo scrittore russo Eduard Limonov, ripreso in un filmato della BBC del 1992 mentre sparava con un kalashnikov verso Sarajevo in compagnia di Radovan Karadzic . Limonov, scrittore e politico ultranazionalista, ha sempre sostenuto di aver sparato solo a un poligono di tiro e che le riprese fossero state manipolate per farlo sembrare coinvolto in azioni contro civili, ma la sua presenza sulla linea del fronte serbo-bosniaco è indiscutibile.
Secondo le fonti dell’intelligence bosniaca citate da Gavazzeni, l’organizzazione di questi “safari” sarebbe stata coordinata dal servizio di sicurezza dello Stato serbo , con il coinvolgimento di Jovica Stanisic, alto funzionario poi condannato per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale. La “copertura” dell’attività venatoria serviva per portare i gruppi a destinazione senza sospetti: alcuni partecipanti si fingevano membri di spedizioni di caccia sportiva diretta nei Balcani, altri si mescolavano a convogli umanitari partiti dal nord Italia, fingendosi volontari mentre in realtà trasportavano denaro e armi.
L’assedio di Sarajevo, iniziato il 5 aprile 1992 e terminato il 29 febbraio 1996, è durato complessivamente 1.425 giorni, diventando uno degli assedi più lunghi della storia moderna. Durante questo periodo furono uccisi 13.952 persone, di cui 5.434 civili, tra cui 1.601 bambini . Le forze serbo-bosniache bombardavano quotidianamente la città con una media di 329 proiettili al giorno, per un totale stimato di oltre mezzo milione di bombe sganciate. Il principale viale della città divenne tristemente noto come “Sniper Alley”, il viale dei cecchini, dove attraversare la strada significava rischiare la vita.
Un rapporto delle Nazioni Unite dell’epoca chiarisce inequivocabilmente la natura degli attacchi: “Tiratori esperti spesso uccidono i loro obiettivi con un singolo colpo alla testa o al cuore, ed è chiaro che hanno esercitato l’intento specifico di colpire obiettivi civili evidenti senza altro scopo che causare morte o gravi lesioni corporali”. Il rapporto confermò che i cecchini operavano in squadre intorno alla città e prendevano deliberatamente di mira civili, obiettivi non combattenti e soccorritori che tentavano di aiutare le vittime, oltre al personale delle Nazioni Unite.
Tra i massacri più devastanti si ricorda quello del mercato Markale del 5 febbraio 1994, in cui 68 civili furono uccisi e 200 feriti da un singolo attacco con mortaio. Le strutture mediche erano sopraffatte dalla scala delle vittime civili, e solo un piccolo numero di feriti poteva beneficiare di programmi di evacuazione medica come l’Operazione Irma del 1993. I dati mostrano che il 1992 fu l’anno con il maggior numero di vittime, con una media di 300 persone uccise al mese , per poi diminuire negli anni successivi ma rimanendo comunque a livelli drammatici.
L’analisi demografica condotta per il tribunale dell’Aja ha rivelato che tra le vittime identificate nel periodo 1992-1994 c’erano 295 bambini, 670 donne e 85 anziani tra i morti, mentre tra i feriti si contavano 1.251 bambini, 2.477 donne e 179 anziani. Le cause principali di morte e ferimento erano bombardamenti, colpi di cecchino e altre armi da fuoco . In particolare, 699 persone furono uccise da cecchini, di cui 253 erano civili, mentre 3.111 furono ferite da cecchini, di cui 1.296 civili. Questi numeri testimoniano la portata della tragedia e il deliberato attacco alla popolazione civile.
In questo contesto di orrore sistematico, l’idea che alcuni individui pagassero per aggiungere ulteriore sofferenza, trattando l’uccisione di esseri umani come un’attività ricreativa, rappresenta un livello di depravazione che sfida la comprensione. Gli esperti di psicologia interpellati per comprendere il fenomeno hanno parlato di persone capaci di controllare i propri impulsi sadici nella vita quotidiana, in attesa di opportunità per esprimerli in contesti in cui ritengono di poter agire impunemente .
Il caso dei “safari di Sarajevo” non è completamente isolato nella storia dei conflitti. Durante la guerra civile libanese del 1975-1990, John Jordan aveva testimoniato di aver già sentito parlare di “tourist shooters” che operavano lungo la “linea verde”, la terra di nessuno piena di cecchini che separava Beirut in due metà. Anche in contesti più recenti, come il conflitto in Ucraina, sono emerse segnalazioni di mercenari e appassionati di armi che si recano nelle zone di guerra, anche se con motivazioni e modalità diverse.
L’inchiesta milanese rappresenta un tentativo significativo di fare giustizia per crimini che rischiavano di rimanere nell’ombra. Gavazzeni ha stimato che i “cecchini del weekend” italiani potrebbero essere stati almeno un centinaio , mentre altre fonti parlano di circa duecento italiani e di molti altri stranieri. Anche se identificare tutti le responsabilità dopo più di trent’anni sarà estremamente difficile, i magistrati sperano di riuscire ad individuare almeno alcuni di loro, specialmente quelli che all’epoca erano più giovani e che quindi sono ancora in vita e potrebbero essere processati.
La collaborazione internazionale sarà fondamentale per il successo dell’inchiesta. Il console bosniaco a Milano, Dag Dumrukcic, ha garantito la “piena cooperazione” del governo del suo paese , dichiarando che le autorità bosniache sono desiderose di scoprire la verità su una questione così crudele e di fare i conti con il passato. Dumrukcic ha affermato di essere a conoscenza di alcune informazioni che contribuiranno a fornire all’indagine. Anche le autorità serbe sono state interpellate, ma hanno respinto le accuse definendole una “leggenda urbana”, una posizione che riflette le persistenti divisioni e tensioni nella regione.
L’apertura dell’inchiesta ha suscitato reazioni diverse. Alcuni osservatori hanno espresso scetticismo sulla possibilità di identificare e processare le responsabilità dopo così tanto tempo, soprattutto considerando che molti dei potenziali testimoni potrebbero essere morti o irreperibili. Altri hanno criticato l’attenzione mediatica sul caso, sostenendo che serva a “satanizzare il popolo serbo”, come ha affermato Radan Ostojic, presidente dell’Organizzazione dei Veterani della Repubblica Srpska, che ha condannato il documentario di Zupanic e le successive indagini.
Ljubisa Cosic, sindaco di Sarajevo Est nell’entità della Repubblica Srpska della Bosnia-Erzegovina, ha persino presentato una denuncia contro il regista Zupanic per diffusione di odio razziale, religioso e nazionale. Ostojic ha sostenuto che “la vera verità” è che durante la guerra “cacciatori provenienti da paesi islamici venivano a Sarajevo per cacciare serbi per la jihad, e in safari i soldati NATO”. Queste affermazioni, prive di prove documentali, riflettono i tentativi di alcune fazioni di ribaltare la narrativa e di negare responsabilità ampiamente documentate.
Tuttavia, la stragrande maggioranza della comunità internazionale e degli esperti di diritti umani sostiene l’importanza di fare luce su questi episodi. Le vittime dell’assedio di Sarajevo ei sopravvissuti meritano giustizia, e ogni responsabile di crimini contro civili indifesi deve essere identificato e processato , indipendentemente dalla nazionalità o dal tempo trascorso. L’impunità per crimini di questa gravità non solo nega giustizia alle vittime, ma crea anche un pericoloso precedente che può incoraggiare comportamenti simili in conflitti futuri.
L’inchiesta della Procura di Milano rappresenta quindi non solo un tentativo di fare giustizia per specifici crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma anche un messaggio più ampio: che nessuno può credere di poter partecipare a massacri di civili e poi tornare tranquillamente alla propria vita quotidiana senza conseguenze. Il fatto che l’Italia abbia deciso di procedere con questa indagine, nonostante le difficoltà e il tempo trascorso, è un segnale importante di impegno verso i principi fondamentali del diritto internazionale e della giustizia universale.
Nei prossimi mesi, il pm Gobbis ei carabinieri del ROS inizieranno a convocare i testimoni indicati nel dossier di Gavazzeni. Sarà fondamentale raccogliere nuove testimonianze, verificare le informazioni già in possesso e tentare di accedere agli archivi classificati in Bosnia e, eventualmente, in Italia. Se emergeranno elementi sufficienti per identificare anche solo alcuni degli italiani che hanno partecipato a questi “safari umani”, i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati e potrebbero iniziare un processo che finalmente porterebbe alla luce una delle pagine più oscure della partecipazione straniera alla guerra in Bosnia.
La storia dei “cecchini del weekend” di Sarajevo è una testimonianza agghiacciante di come gli istinti più bassi dell’essere umano possono emergere quando le circostanze lo permettono e quando si crede di poter agire impunemente. È una storia di ricchi annoiati che trasformarono la sofferenza di un popolo assediato in un gioco macabro , pagando somme enormi per il privilegio di togliere vite umane come se fossero in una riserva di caccia. E mentre le ferite di quella guerra non si sono ancora rimarginate nei Balcani, l’inchiesta italiana offre una speranza, forse l’ultima, che almeno alcuni di quei “cacciatori” possono essere chiamati a rispondere dei loro crimini davanti alla giustizia.
Titolo: Safari Umani a Sarajevo: la Procura di Milano Indaga sui “Cecchini del Weekend” Italiani
Descrizione SEO: La Procura di Milano apre un’inchiesta sui ricchi italiani che negli anni ’90 pagavano fino a 100.000 euro per sparare sui civili durante l’assedio di Sarajevo. Testimonianze esclusive, documenti segreti e il ruolo dell’intelligence italiana in uno dei capitoli più oscuri della guerra in Bosnia.